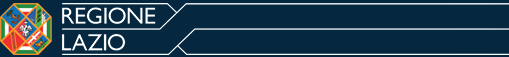Comune di Cave
Scarica il patto di collaborazione per Cave
Nel corso del 2021 con il progetto Ossigeno siamo intervenuti realizzando impianti urbani eterogenei con le seguenti essenze arboree:
Comune di Cave
Scarica il patto di collaborazione per Cave
Nel corso del 2021 con il progetto Ossigeno siamo intervenuti realizzando impianti urbani eterogenei con le seguenti essenze arboree:
Albero alto fino a 25 m con chioma sempreverde; il tronco presenta una scorza rugosa grigio-brunastra, screpolata in placchette subrettangolari. Grazie alla particolare resistenza alle avversità e ai danni da inquinamento è molto comune come albero ornamentale nel verde urbano.
Latifoglia arborea caducifoglia dal portamento vigoroso e globoso. È specie con buone potenzialità di colonizzazione di terreni aperti grazie ai frutti (disamare) alati; ambiente: boschi e boscaglie, siepi
È un albero di grandi dimensioni dalla chioma ampia e globosa, che può raggiungere un’altezza di 35 m e un tronco di oltre 3 m di diametro; la corteccia inizialmente grigiastra e liscia, negli esemplari maturi diventa rossastra e frammentata in grandi placche che tendono a staccarsi. Il frutto è una doppia samara. Le foglie, opposte, sono lungamente picciolate (5–15 cm), di 10–15 cm di lunghezza e pari larghezza, pentalobate con margine debolmente dentato; la pagina inferiore è di colore grigio-verde, glaucescente. Il legno è molto pregiato e trova utilizzo nella fabbricazione di strumenti a corde. Ambiente: boschi mesofili montani. Consigli per la coltivazione e la cura
Arbusto sempreverde alto fino a 4-5 m, ramificato dalla base, con i rami giovani pubescenti. Ampiamente utilizzato per siepi e arredi urbani anche per le abbondanti fioriture prolungate dall’autunno alla primavera; ambiente: macchie, boschi termofili, rupi.
Grande albero, che può raggiungere i 35 m di altezza e diametri superiori al metro, meno longevo delle altre querce caducifoglie. Ha tronco dritto e slanciato, in bosco ramificato dal terzo superiore e chioma mediamente densa. La corteccia, dapprima grigia e liscia, dopo una decina di anni forma solchi profondi di colore rossastro, più evidenti nella stagione vegetativa. Le foglie sono di forma molto variabile, tardivamente caduche e scabre superiormente; spesso profondamente lobate, quasi a toccare la nervatura centrale, in numero di 4-7 lobi per lato, sono però molto variabili, anche nella stessa pianta e/o in diverse fasi fenologiche. Le ghiande sono grandi e coperte fino a metà da una cupola emisferica, formata caratteristicamente da squame divergenti lunghe anche 1 cm; contengono molto tannino e sono perciò poco appetite dagli animali. Il legno è poco pregiato; in passato veniva impiegato per la produzione di traverse ferroviarie e doghe da botti, ma oggi è utilizzato quasi esclusivamente come legna da ardere e per la produzione di carbone. È una specie tendenzialmente mesofila, sebbene possa vegetare in un ampio range altitudinale, essendo, di fatto, limitata verso il basso dalla lecceta e verso l’alto dalla faggeta. Nei riguardi del terreno l'optimum è rappresentato da suoli vulcanici a reazione sub-acida.
Quercia caducifoglia dalla chioma ampia e rada, che raramente raggiunge i 20-25 m di altezza; ambiente: boschi termofili, arbusteti su pendii assolati
Pianta suffruticosa della famiglia delle Lamiaceae, alta al massimo mezzo metro e legnosa solo alla base, dall’intenso e caratteristico odore. Le foglie sono verdi-grigiastre per la presenza di peli stellati, a lamina lanceolata allungata e disposte in posizione opposta lungo il fusto. Il nome comune della specie, come anche quello scientifico del genere (Lavandula), che richiama il gerundio latino del verbo lavare, trae origine dal fatto che queste piante erano molto utilizzate nell'antichità (soprattutto nel Medioevo) per detergere il corpo. Ancora oggi la lavanda è diffusamente coltivata (in Italia soprattutto in Piemonte e Toscana) per l’utilizzo nell’industria cosmetica come base per la profumazione di saponi e detersivi. Nel Lazio è presente come alloctona casuale nella zona costiera di Latina in ambiente rupestre.
Albero caducifoglio dal tronco eretto leggermente tortuoso e rami opposti ascendenti, con corteccia liscia grigiastra e opaca. La chioma è ampia con foglie composte imparipennate. È particolarmente adatta alla silvicoltura e a interventi di rimboschimento.
Albero caducifoglio di grandi dimensioni a foglie caduche, cuoriformi e margine seghettato, pubescenti nella pagina inferiore. I fiori, forniti di brattea con funzione di ala, sono molto profumati e melliferi. Ambiente: boschi di latifoglie.
Albero ampiamente coltivato per la grande importanza economica nella produzione del legname e, specie in passato, nell’industria alimentare. Presente dopo l’ultima glaciazione in alcune aree di rifugio dell’Europa sudorientale e forse dell’Italia peninsulare, il suo areale è stato ampiamente esteso ad opera dell’uomo già in epoca preromana. Il castagno è una specie molto longeva, dal fusto colonnare, fessurato longitudinalmente negli esemplari maturi, e chioma espansa e rotondeggiante; può raggiungere una altezza variabile dai 10 ai 30 metri. Presenta grandi foglie lanceolate a margine seghettato; il frutto, la nota castagna, è un achenio ricco di amido racchiuso, in numero di 1-3, in un involucro spinoso comunemente chiamato riccio. La fioritura avviene a maggio-giugno e la fruttificazione a settembre-ottobre. Ambiente: boschi collinari e montani, talora monospecifici Consigli per la coltivazione e la cura
Albero caducifoglio anche di grandi dimensioni, che colonizza spesso ambienti rupestri e ruderali (da cui il nome volgare di “spaccasassi”); ambiente: boschi e boscaglie, ruderi e mura. Talora introdotto.
Pianta arbustiva sempreverde a portamento cespuglioso, alta fino a 6 m, con fusto eretto e ramificato fin dalla base. Le foglie sono lanceolate, lunghe 8-14 cm, coriacee e lucide superiormente e presentano specifici adattamenti all’aridità. Allo stato spontaneo non sopporta temperature inferiori ai 5-7 gradi centigradi. Fiori ermafroditi raccolti in corimbi, di colore che va dal bianco al roseo o al giallo e al rosso carminio, molto vistosi. L'oleandro è una pianta velenosa in tutte le sue parti per la presenza di alcaloidi tossici, ma in particolare le foglie contengono glucosidi, oli eterei e acidi organici fortemente tossici. In natura l’oleandro cresce prevalentemente in ambienti sassoso-sabbiosi lungo il greto di fiumi e torrenti a portata intermittente (le fiumare calabre e siciliane). Per la bellezza delle fioriture l’oleandro è ampiamente utilizzato, specie nel centro-sud, come ornamentale in giardini privati e alberature stradali ma anche per rinverdire scarpate autostradali.
Il cedro del Libano è una conifera originaria del Mediterraneo orientale (Libano, Siria e Turchia) che allo stato spontaneo raggiunge i 40 metri di altezza (eccezionalmente fino a 60 metri!). I grandi rami ascendenti a 90° gli conferiscono il caratteristico portamento a "candelabro". Col passare del tempo la cima tende ad appiattirsi. Le foglie aghiformi di colore verde scuro, lunghe fino a 3 cm, sono portate sia singolarmente sui giovani rametti, sia in ciuffi di 20-30 su corti rametti laterali. Come tutte le conifere, non presenta fiori ma strobili: grigio-verdastri i maschili, lunghi fino a 5 cm e giallastri a maturità, verdastri i femminili, che dopo la fecondazione assumono consistenza legnosa (pigne) sfaldandosi e liberando i semi. Oggi nella sua zona di origine sopravvivono solo poche centinaia di esemplari monumentali.
Albero sempreverde, molto longevo, alto fino a 30 m (gli esemplari più vecchi possono superare i 50 m), con tronco diritto e robusto e chioma di forma molto variabile, da conico-piramidale allungata, spesso ramificata fin dalla base (var. pyramidalis o 'stricta') a espansa con rami patenti o quasi orizzontali (var. horizontalis). La corteccia è grigiastra e fibrosa, fessurata in senso longitudinale. Il legno è bicolore, con duramen bruno e alburno bianco-giallastro; sono presenti falsi anelli dovuti al riposo estivo che la specie attua come adattamento alla siccità estiva. Le foglie sono ridotte a squame di 1 mm, strettamente embricate e appressate ai rametti. I fiori femminili dopo l'impollinazione si sviluppano in strobili subsferici, verdi quando immaturi. Specie originaria del vicino oriente (Creta, Cipro, Siria), è stato introdotto in Italia in epoca antichissima, forse dagli Etruschi o addirittura dai Fenici, ed è attualmente diffuso in tutto l'areale del Mediterraneo dove si trova sia spontaneo che coltivato come pianta ornamentale. Data l’estrema frugalità è utilizzato anche a scopo forestale per consolidare terreni ripidi e sassosi.
Per maggiori informazioni consultare l’informativa privacy e la cookie policy.